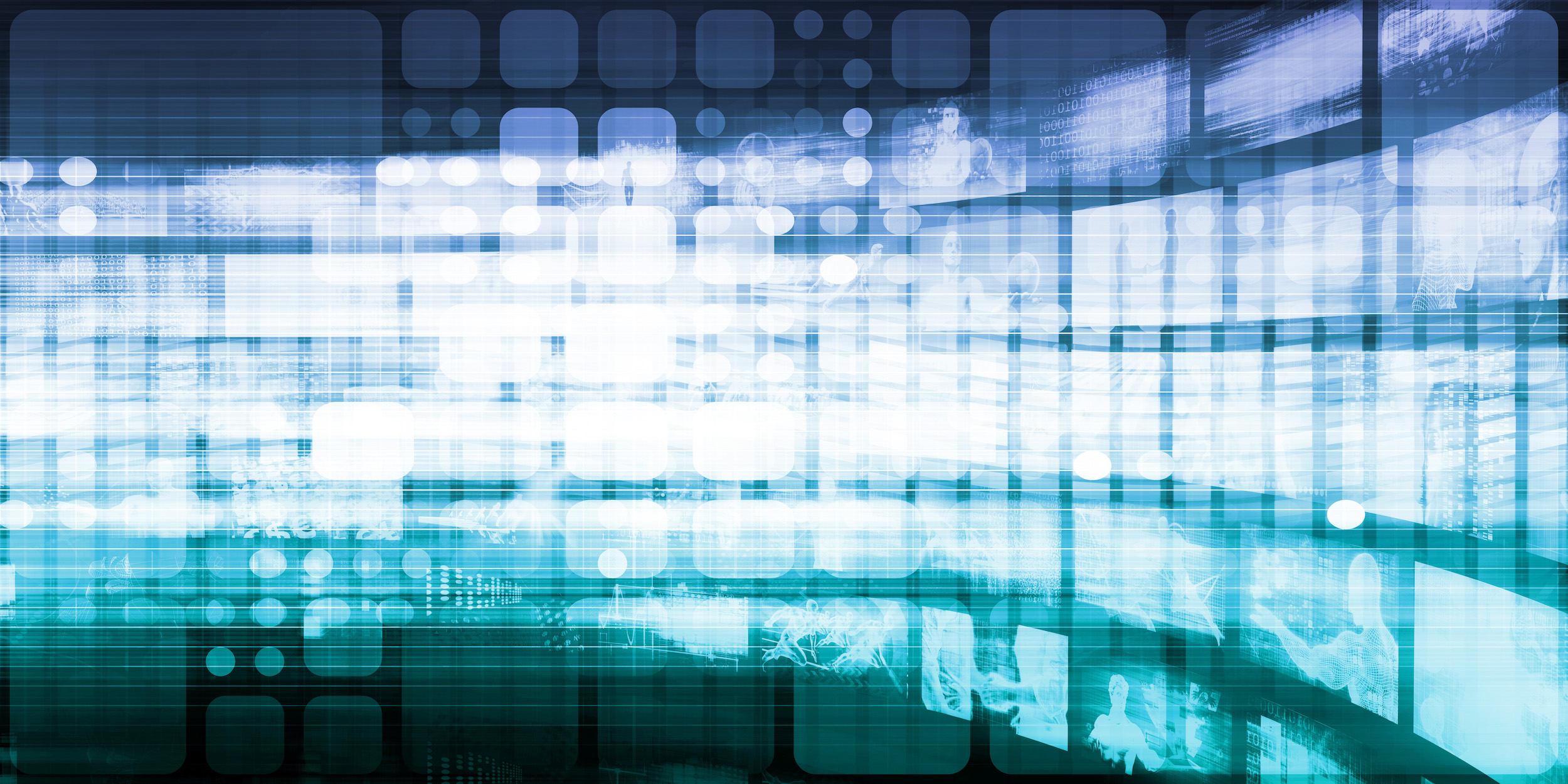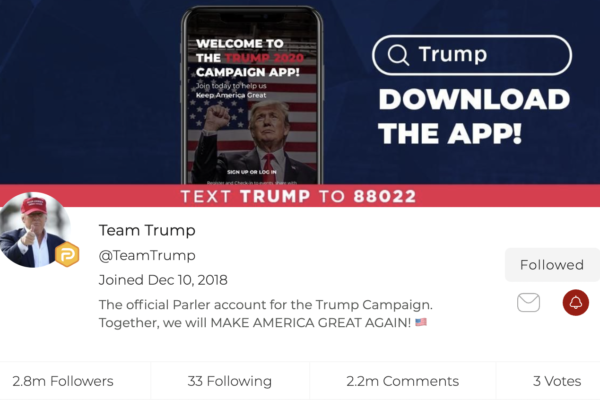Potremmo invocare il pudore, forse.
Ammettere che si è affaticati dopo 8-10 ore di videochiamate non risulta facile. Col pensiero rivolto a chi lavora in una corsia d’ospedale o alle casse d’un supermercato, più spesso decidiamo di tacere.
Però la fatica da Zoom, “zoom fatigue” la chiamano nel mondo anglosassone, esiste. L’impressione – tanto per cambiare – è che negli Stati Uniti se ne parli di più che da noi. Eppure in Italia, potrebbero essere interessate da questo fenomeno oltre 6 milioni e mezzo di persone impegnate nel remote working.
Accanto alla Zoom fatigue esiste anche una più generale stanchezza da Internet, di cui si discute dal 2014: «scorri, aggiorni – scriveva al tempo Rawiya Kameir, docente di comunicazione pubblica alla Syracuse University – e leggi compulsivamente le timeline: alla fine ti senti davvero esausto. Una specie di ansia che accompagna il sentirsi intrappolati in un vortice di pensieri altrui». Ai pensieri, oggi, dobbiamo aggiungere le immagini, i volti più o meno sfocati o le sigle che rappresentano gli altri quando non vogliono mostrarsi, poi i suoni, le voci.

Su Eurozine, l’esperto olandese di culture digitali Geert Lovink ha compilato una anatomia della fatica da Zoom (che vale anche per tutte le altre piattaforme di lavoro da remoto: Meet, Skype, Teams).
Si tratta di una lettura confortante per chi – in qualche maniera – dalla Zoom fatigue risulta afflitto: egli si riconoscerà in alcune manifestazioni di questa condizione.
Proviamo a definirne, allora, i contorni.
Tutti sappiamo che quando conversiamo con qualcuno, il nostro cervello elabora tanto il significato delle parole quanto il cosiddetto linguaggio del corpo: le espressioni del viso, i movimenti impercettibili, e ricava informazioni utili da decine di segnali non verbali.
Trascorrere ore e ore in riunioni, davanti al computer, risulta faticoso dal punto di vista fisico, cognitivo ed emotivo non soltanto perché manca la prossemica ad aiutarci. Siamo provati perché la nostra mente cerca di dare un senso alle cose che vede e ascolta in circostanze del tutto particolari. Si attivano processi che normalmente sarebbero «inconsci e che operano (…) per aiutarci a interpretare ciò che stiamo vivendo». E ciò che stiamo vivendo differisce da una comunicazione che, fino a ieri, consideravamo norma.
Ecco un elemento essenziale.
Quando siamo davanti a una webcam controlliamo in continuazione la nostra immagine, vittime di una specie di riflesso condizionato. Guardiamo gli altri e sempre riguardiamo noi stessi. Verifichiamo la nostra presenza buttando lo sguardo alla nostra immagine.
Dopotutto ci stiamo esibendo in una performance, sotto l’occhio di una telecamera per un pubblico sia pure limitato; alcuni di noi addirittura possiedono uno speciale occhio di bue, economico e alla portata dei più (la ring light); oggetto costruito apposta per illuminare alla perfezione una sessione di Zoom. Alla fine torniamo sempre alla nostra immagine, sia che parliamo o ascoltiamo: vogliamo controllare se stiamo bene, se andiamo bene in video. E tutto questo accade come se nella conversazione portassimo con noi uno specchio. Uno specchio, sottobraccio.

Date queste premesse, non è sbagliato affermare che la videochiamata e il controllo ossessivo della propria immagine instaurano un nuovo tipo di relazione: «una relazione “Io-Me-Tu”», così la definisce M. L. Sacasas, esperto di tecnologie. Insomma: io parlo, e nello stesso tempo guardo anche me stesso e contestualmente mi rivolgo all’altro interlocutore, e poi ricomincio, mi riguardo, e guardo l’altro, seguendo e ripetendo lo stesso schema. Questo movimento incessante, non solo oculare, genera stress, logora. La zoom fatigue è una fatica iterativa.
Di solito, o almeno finora, in una conversazione un essere umano aveva la percezione di sé esclusivamente attraverso la propria voce. Gli unici abituati a controllare l’inquadratura nei monitor di servizio, a lavorare con Io-Me-Tu, sono i conduttori televisivi: per loro risulta essenziale capire quale sia il segnale della messa in onda, quello che vedono i telespettatori a casa. Nel lavoro da remoto assistiamo a qualcosa di simile: entra in gioco uno specchio il cui riflesso appare nel computer, nella piattaforma. Ci rivolgiamo freneticamente allo specchio per rassicurarci circa la nostra minima messa in onda. Eccola qui la fatica; ed ecco perché molti preferiscono chiudere la webcam. Un processo di questo genere comporta «un dispendio persistente di lavoro cognitivo poiché – chiarisce Sacasas – mi occupo tanto della mia immagine quanto di quelle degli altri partecipanti».
La fatica digitale, insomma, prende forma nell’evidente assenza del corpo altrui, prima cosa alla quale pensiamo quando ci viene chiesto in cosa consista il lavoro da remoto; ma soprattutto ne subiamo gli effetti a causa di una nostra doppia presenza, una corporea e una incorporea, alla discrasia dell’Io-Me-Tu.
Scrivono i ricercatori del Journal of embodied research: «la videoconferenza è psicologicamente impegnativa perché il nostro cervello ha bisogno di elaborare un sé come corpo e come immagine. (…) La nostra immaginazione colma le lacune e rende necessario elaborare, selezionare cosa ignorare. Controlliamo continuamente lo schermo, e quindi la nostra immagine: come se avessimo bisogno di una garanzia continua che la connessione esista ancora» e che noi siamo lì.
Ancora una volta, nella sua millenaria vicenda, l’essere umano sembra impaurito e alla ricerca di rassicurazione, terrorizzato dall’abbandono, preoccupato che possa lasciarlo solo addirittura la sua immagine riflessa, (niente di più vicino al mito di Narciso, e al rincorrersi delle domande poste dal giovane e dalla ninfa Eco: «chi è là?», «chi è là?, chi è là?»…). L’uomo continua a cercare il proprio riflesso, sperando di trarne conferme o una qualche misericordia.
C’è di più.
Quando siamo al museo, davanti a un quadro, spiega sempre Sacasas, immediatamente sappiamo dove posizionarci per guardarlo meglio: ci mettiamo alla giusta distanza. Eppure non troviamo scritto a terra “fermati proprio qui per guardare meglio l’opera”. Allo stesso modo, in una conversazione in presenza, con due o più persone, capiamo subito quale sia lo spazio vitale per dialogare, il luogo in cui posizionarci, la giusta distanza ancora una volta. E questo a seconda del tipo di conversazione, e di relazione.

In videopresenza invece si realizza la mimesi di una comunicazione faccia a faccia, in una sorta di simultaneità, in cui il corpo non può trovare una sua giusta posizione se non in relazione alla webcam. E se non in base alla fissità della stessa webcam.
Oltre una certa misura, non possiamo girare intorno al computer, lontano dal computer, non possiamo metterci di lato, avvicinarci, scegliere la prospettiva: la giusta distanza la decide l’inalterabile focale della webcam, mica noialtri. La tecnologia posiziona l’essere umano; e il nostro faccia a faccia risulta condizionato, determinato. Ravvicinato e senza corpo. Un vero grumo di contraddizioni.
Due artisti concettuali, Annie Abrahams e Daniel Pinheiro, hanno illuminato la cornice di questo faccia a faccia: «vediamo un viso incorniciato come quando eravamo bambini in una culla, mentre i nostri genitori ci guardavano dall’alto in basso. Successivamente è diventata la cornice delle interazioni con i nostri amanti, a letto. Ecco, durante le videoconferenze siamo sempre collegati a qualcosa di molto intimo, anche in situazioni professionali». Forse il paragone risulterà ardito, ma la riflessione mette a fuoco un passaggio sul quale vale la pena riflettere. La cornice stringe il nostro volto solo in un primo piano, talvolta in un primissimo piano. Non abbiamo la possibilità di utilizzare altre inquadrature.
Che faccia a faccia è quello in cui cercare lo sguardo dell’altro significa evitare lo sguardo dell’altro?
Quando fissiamo le webcam per “guardare l’altro negli occhi” finiamo per evitare lo sguardo del nostro interlocutore: le due cose si elidono. Appaiono letteralmente inconciliabili.
Una recente ricerca britannica ha isolato un dato sconvolgente che emerge dalle varie forme di lockdown: trascorriamo 13 ore al giorno davanti agli schermi. Viviamo buona parte di questo tempo nelle piattaforme che consentono il lavoro a distanza, o la didattica a distanza, per chi studia. Da ecosistema Zoom sta diventando domicilio, coatto per giunta.

Quando passiamo molte ore in un luogo, poi non ne possiamo più. Ecco perché – a differenza della prima quarantena – molti stanno evitando le videochiamate con amici e parenti.
Scrive un designer di Rotterdam: «se il lavoro esaurisce il mio tempo per le videochiamate, intuitivamente sono portato a interrompere tutte quelle più informali che faccio con amici e conoscenti. Tutto questo mi rende triste, mi fa sembrare scortese. Ma è un atteggiamento di autoconservazione che porta all’isolamento». Alcuni hanno cominciato a parlare dei rischi di burnout per un uso eccessivo delle videochiamate. Il tema è sempre lo stesso: la ripetizione continua di uno schema che rende i giorni tutti uguali. Ore e ore videopresenza, come l’ha definita Mark Zuckerberg con mirabile ossimoro.
Qualcuno comincia a chiedersi: «quando torneremo alla vita reale?»
Mi viene da rispondere con un’altra domanda: «cosa c’è di irreale in tutto questo?»
Certo, l’eccezionalità della pandemia, nel racconto talvolta, s’accompagna a una sua presunta irrealtà (un brutto sogno); ma in tutto questo abbiamo – realmente – infilato una porzione importante della nostra vita dentro gli schermi, nel concretissimo e intangibile ecosistema digitale.
Nulla di illusorio: viviamo proprio lì dentro.
Non siamo semplicemente davanti agli schermi per 13 ore, quindi più della metà di un giorno intero, la quasi totalità delle ore di veglia di un adulto.
Gli schermi rappresentano ormai la lente attraverso la quale osserviamo il mondo. Prima di tutto questo, l’uomo osservava il mondo, con i suoi occhi, le cose nel mondo, le persone nel mondo, la natura, guardava tutto direttamente, senza filtri; e solo talvolta utilizzava uno schermo, una lente: il cinema, la tv, il computer, lo smartphone.
Adesso il rapporto si è invertito.
La norma è osservare il mondo da uno schermo, e l’eccezione sta nell’osservare il mondo senza il diaframma di uno schermo.
La norma è concentrare lo sguardo su una superficie illuminata artificialmente, l’eccezione sta nel guardare con luce naturale o col buio.
Mai come in questo momento avvertiamo la necessità di costruire categorie interpretative che superino la dicotomia materiale-immateriale, virtuale-reale, analogico-digitale. Serve una lingua che superi queste contrapposizioni. Molti, oggi, parlano di posto di lavoro ibrido, di interazione ibrida, con la presenza alternata nel luogo di lavoro fisico e in quello digitale. Ibrido è aggettivo che descrive e non spiega.
E però ibrido ha un etimo legato al greco hybris, la tracotanza di fronte agli dei, l’eccesso, ma anche la violenza. E ibrido è pure bastardo: generato da animali non simili. La verità è che la genesi di questo aggettivo non possiede nulla di neutro, sebbene venga spesso così utilizzato: come sinonimo di duale, di incrocio, di qualcosa che è figlio di una sintesi paritaria, di un’alternanza. Ibrido porta con sé un’ipoteca di significati negativi. E non c’è nulla di neutro nel modo in cui lavoriamo. Non c’è una sintesi, non c’è mescolanza, non c’è alternanza. Per adesso abbiamo assistito a un’annessione, a un processo inevitabile (ancora una volta) di conquista.
Stavolta non avevamo scelta.
Ma dopo?