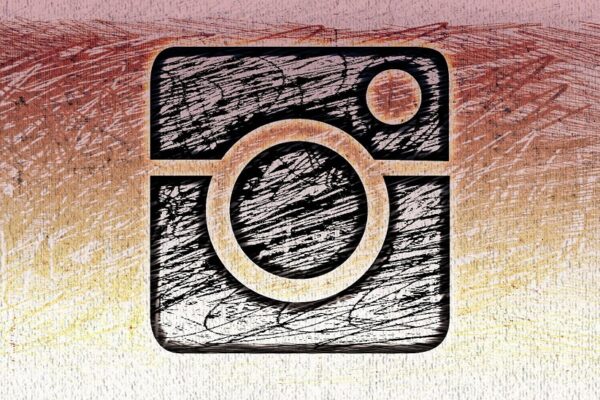(Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su China Files nel novembre 2019)
Fino a oggi solo scarne punizioni. Bacchettate sulle dita che hanno l’aspetto di multe. Ma che sono multe salate solo per chi ha lo sguardo appannato dal valore assoluto di una sanzione, e non da quello relativo. Per chi si fa offuscare da una cifra enorme, 5 miliardi di dollari, pensando che 5 miliardi di multa siano tanti per Facebook. Non è così.
C’è chi pensa invece che quelle punizioni non siano più sufficienti.

Gli Stati Uniti hanno deciso di mettere sotto scacco le techno-corporation della Silicon Valley. Hanno deciso di farlo con una delle armi più potenti che il sistema possiede: l’antitrust. In questo momento sono in piedi diverse inchieste sui comportamenti delle grandi aziende digitali, comportamenti che avrebbero illegalmente soffocato la concorrenza. Diverse inchieste: una del Dipartimento di Giustizia, una della Agenzia federale sulle comunicazioni, condite da varie audizioni del Congresso, cui devono aggiungersi le indagini di oltre 50 procuratori generali di quasi tutti gli Stati. Per utilizzare un’immagine pop che piacerebbe ai tardo adolescenti della Silicon Valley, potremmo dire che hanno messo insieme gli Avengers della giustizia contro gli Avengers del digitale.
Questi ultimi se la passano piuttosto male, addirittura hanno subito l’onta, da parte del Congresso degli Stati Uniti, di consegnare le mail inviate e ricevute dagli amministratori delegati, per capire se lì dentro ci sono prove di comportamenti anti-concorrenziali. Per capirci le mail di Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page e Sergey Brin.
Per le grandi piattaforme assistere a questo spettacolo è come contemplare una specie di enorme, affilata e forse definitiva, spada di Damocle che pesa e si agita sulla loro testa. Nei prossimi mesi queste indagini arriveranno a un esito e questo esito potrebbe essere funesto oppure no, letale oppure no.
Capiremo, insomma, se gli Stati Uniti considerano le techno-corporation un problema o una risorsa.
Capiremo inoltre se il sistema americano ha la capacità di valutare le techno-corporation in maniera unitaria circa gli interessi e la sicurezza nazionale e quindi di proiezione strategica verso l’esterno.
Capiremo infine se da queste indagini risulterà un nuovo assetto, problematico per gli Stati Uniti e vantaggioso per la Cina, dello spazio digitale e dei suoi protagonisti.
Che le techno-corporation rappresentino monopoli può essere considerato un dato di fatto, una considerazione scontata se si guarda esclusivamente ai rispettivi mercati e se si circoscrive l’analisi al mondo occidentale. D’altronde la tensione a diventare monopolisti rappresenta un dato essenziale della loro rapace cultura d’impresa. Un aneddoto spesso citato riguarda Peter Thiel, tra i fondatori di PayPal e tra i primi investitori e consiglieri di amministrazione di Facebook, che nel suo corso all’università di Stanford insegnava proprio come costruire monopoli. Siccome nella Silicon Valley sono tutti secchioni, questa materia l’hanno studiata alla perfezione e hanno imparato e applicato la lezione: Google è un quasi monopolista nel settore delle ricerche sul web, Facebook lo è nei social network, Amazon nel commercio elettronico.
Le accuse
Tutte e tre, Amazon, Facebook e Google, sono leader nel settore della pubblicità online, il che equivale a dire che ciascuna di esse è monopolista nella pubblicità online applicata al proprio ambito: social network, e-commerce, ricerca.
Apple non è monopolista nella vendita degli smartphone e dei servizi ma – secondo le accuse – favorisce i suoi prodotti nello store (l’App Store) delle applicazioni.
Quasi tutte hanno acquisito aziende per consolidare una posizione dominante (pratica frequente in molti mercati). I casi più rilevanti sono rappresentati da Google che ha comprato Double Click e YouTube, e da Facebook che ha acquistato WhatsApp e Instagram.
Vi sono pagine web dedicate esclusivamente a elencare le acquisizioni delle techno-corporation: 227 sono quelle targate Alphabet (l’azienda che controlla Google), Amazon ne ha realizzate 99, mentre Facebook si ferma a sole 76 tra acquisizioni e fusioni.
Potremmo dire che tutte le grandi aziende della Silicon Valley hanno fatto shopping per incorporare la concorrenza o per internalizzare rapidamente competenze che non possedevano. E nel corso del tempo hanno sempre più recintato il proprio perimetro d’azione, per far sì che l’utente-cliente rimanesse sempre di più all’interno delle applicazioni, cercando di offrigli il maggior numero di servizi possibile. E quando l’utente è così confinato nel recinto di una techno-corporation, tende a scegliere per lo più le applicazioni o le soluzioni che sono dentro a quel recinto: un cliente Amazon sceglierà con più facilità un prodotto targato Amazon, un utente di Google sceglierà un video di YouTube.
Le piattaforme di vendita di beni di terze parti o meno (Amazon, l’App Store di Apple) e quelle di servizi (per la vendita di pubblicità, Facebook Business Manager e AdWords di Google), unite alla conoscenza molecolare dei dati dei clienti-utenti chiudono non metaforicamente il cerchio. Costituiscono un altro recinto, forse il più importante, in cui le techno-corporation decidono chi sta dentro e a quali condizioni, a quale prezzo. D’altronde è casa loro e fanno come vogliono.
Se queste sono le accuse cerchiamo di capire cosa potrebbe accadere se tutti quei giudici messi assieme decidessero di comminare sanzioni.
Uno.
Lo scenario più confortevole, ideale potremmo azzardare, per la Silicon Valley sta nel continuare a utilizzare le multe come la sanzione massima applicabile. A ben guardare, una qualsiasi multa apparirebbe come un bastone che nasconde la proverbiale carota. Una sanzione pecuniaria, per quanto salata, non può mettere in crisi l’attuale assetto delle techno-corporation, non ne mette in crisi il potere e le capacità di crescita, non ne mette soprattutto in crisi la tenuta finanziaria. Anche immaginando multe dal valore superiore ai 5 miliardi di dollari la Silicon Valley è, e sarà, in grado di assorbirle.
Stiamo parlando di aziende che hanno riserve di liquidità che vanno dai 44 miliardi di dollari di Facebook ai 245 miliardi di Apple, passando per gli oltre 120 di Alphabet. Se invece guardiamo al volume d’affari: Alphabet ha fatturato nel 2018 oltre 135 miliardi di dollari e profitti netti per quasi 10 miliardi di dollari, Facebook 55,8 miliardi e utili per poco più di 22 miliardi.
La multa, insomma, andrebbe interpretata come un avvertimento, l’ultimo avvertimento inviato da un ipotetico e benevolo soggetto regolatore, il cui sottotesto sarebbe: da adesso in avanti basta acquisizioni che consolidano una posizione dominante. Se dovesse emergere un nuovo unicorno, un nuovo campione digitale, nei settori di mercato in cui siete leader, lasciate che sia. Affrontate i rischi del mercato come fanno – più o meno – tutti gli altri.
Due.
La parola break-up, smembramento, sembra essere il vero terrore della Silicon Valley. Ed è una parola che negli ultimi mesi ha cominciato a essere pronunciata con frequenza sempre maggiore nei dibattiti per le presidenziali – per lo più da parte democratica, e tra i candidati Elizabeth Warren su tutte – ma anche nei corsivi, nei talk show, tra gli esperti. Una parola dal suono sinistro che prevede il lacerare, il fare a pezzi, lo smembrare appunto, creature che sono state pensate e assemblate per crescere nel segno di un allargamento costante del proprio perimetro di attività, un allargamento che fagocita e integra; smembrare, in questo senso, è quasi un pensiero contro natura se applicato alle techno-corporation. E vedremo più avanti quanto sia contro-natura l’ipotesi di frazionamento se applicata al nucleo originario di qualunque piattaforma, cioè al software, agli algoritmi.
La parola smembramento e la senatrice sono i veri convitati di pietra delle registrazioni di Mark Zuckerberg che il sito The Verge ha pubblicato lo scorso 1° ottobre. In quegli audio il grande capo di Facebook ha ammesso che un eventuale break-up sarebbe un problema serio, così come una presidenza Warren e che tuttavia egli sarebbe pronto a una battaglia legale. Infine sostiene che di fronte sciogliere o spezzettare le techno-corporation non risolverebbe i problemi anzi potrebbe aumentarli, perché diminuirebbe gli investimenti in sicurezza.
Proviamo allora a costruire una pura ipotesi di scuola: capire se davvero le grandi aziende digitali possono essere smembrate, a quali costi, secondo quali modalità potrebbe attuarsi quello che, con termine sciatto e abusato, si definisce spezzatino. E vedere se davvero è ipotizzabile una suddivisione in parti.
Cominciamo da Facebook che tra le aziende della Silicon Valley è quella che più di tutte ha subito scossoni nell’ultimo anno e mezzo, ha visto crollare la propria reputazione, ha sofferto l’urto della politica e una critica diffusa, e crescente, da parte dei media che l’hanno accusata di ogni nefandezza.
L’azienda di Menlo Park potrebbe essere smembrata in un massimo di 4 parti: i 2 social network, cioè Facebook stesso e Instagram, e i due servizi di messaggistica: WhatsApp e Messenger. O ancora le autorità potrebbero procedere a una soluzione 3 vs. 1, lasciando da solo Instagram che ha prospettive di crescita promettenti.
Oppure il taglio potrebbe avvenire lungo la linea dei ricavi: da un parte tutti i social network e i servizi di messaggistica e dall’altra Facebook Business Manager, ovvero il sistema che gestisce la e orienta la raccolta pubblicitaria di Facebook. L’uno senza gli altri ha poco senso, è vero; ma si potrebbe immaginare una sorta di contratto di servizio tra chi gestisce gli utenti e chi la pubblicità e remunerare il processo che collega l’uno agli altri. Sul modello del mercato dell’elettricità: c’è chi gestisce la rete, chi produce, chi distribuisce e chi vende.
Tuttavia si tratta davvero di un’ipotesi di scuola.
Certo una volta immaginato lo smembramento, resterebbe una domanda ulteriore: chi avrebbe la forza e la liquidità per acquistare mezza Facebook o anche solo un terzo di Facebook?
Provare a ragionare su come frazionare il social network di Zuckerberg introduce una questione più sostanziale, ed è un argomento che in realtà vale per tutte le techno-corporation, come cioè si possano considerare soluzioni di smembramento per aziende in cui la dimensione fisica non è prevalente. Nel caso delle piattaforme digitali il cuore dell’attività risiede in un oggetto di enorme valore, un oggetto segreto, iper complesso e immateriale: l’algoritmo. L’algoritmo è centrale per tutte le techno-corporation, forse a eccezione di Apple, e rappresenta il cuore della loro attività. L’algoritmo per quanto possa ricordare un brevetto, una formula chimica, non lo è: il valore risiede nella formula in sé, nella lunghissima sequenza di istruzioni. Se è difficile, ma alla lunga fattibile, dividere in due una grande banca, anche tenendo conto delle componenti immateriali, come si fa a dividere in due una formula? Come si fa smembrare un software da milioni di righe di codice, in cui l’integrazione tra le varie parti è assoluta, senza smembrare il software nel suo complesso? Come si fa in un’ultima analisi a frazionare una sequenza di istruzioni, senza interrompere la sequenza stessa? Senza cioè, e questo è l’elemento decisivo, rischiare di comprometterne il funzionamento. Un regolatore, una qualunque autorità giudiziaria avrebbero difficoltà a giustificare un comportamento con cui si mette a rischio la capacità produttiva di un’azienda dopo una pronuncia in cui – in teoria – si esaltano le virtù del libero mercato.
Ecco perché a Menlo Park, da un anno almeno, si dedicano con inesauribile lena a integrare l’integrabile, a integrare al massimo livello l’algoritmo. A fare di 4 uno, a comporre una sintesi, immaginiamo, di database e server, e quindi di funzioni, tra social network e servizi di messaggistica che fanno capo tutti a Mark Zuckerberg. L’idea è quella di rendere interoperabili, questo il termine utilizzato in un post dello scorso marzo, le diverse applicazioni per favorire conversazioni e interazioni in gruppi ristretti. Era l’epoca in cui il grande capo di Facebook si lasciò fotografare a una convention con una scritta dal sapore grottesco che brillava alle sue spalle: the future is private. Al netto di quanto potesse, o possa, apparire ridicola e insincera una simile dichiarazione di principio, rimane che a Menlo Park intendono privato nel senso di conversazioni private tra utenti delle diverse piattaforme, e quindi la corsa all’integrazione di pezzi di ferro e pezzi di codice consiste in una corsa a rendere concreto quel futuro privato, così da rendere più complicata qualunque idea di smembramento di tutte e 4 le macro-componenti dell’azienda.
Quale che sia la capacità di integrare a breve le diverse creature, un elemento essenziale della prodigiosa profittabilità dell’azienda di Zuckerberg risiede in Facebook Business Manager: il sistema di gestione delle inserzioni pubblicitarie. Sistema che già adesso permette di programmare e acquistare la pubblicità, non solo su Facebook e Messenger, ma contemporaneamente anche su Instagram e in parte su WhatsApp, realizzando un’ulteriore sintesi operativa. Se Facebook è così incistato in Instagram, Messenger e WhatsApp, così fuso, così integrato, tanto da essere una cosa sola nella componente di software, rompere questa armonia combinata potrebbe risultare piuttosto complicato. Non impossibile ma davvero difficile.
Quale che sia l’esito di una tale lacerazione nel corpo vivo della creatura di Zuckerberg, questa ne uscirebbe comunque molto ridimensionata nel volume d’affari e soprattutto in quella preminenza assoluta, globale, nel mondo dei social network che ha raggiunto in soli 11 anni.
Procedere allo smembramento di Google risulterebbe altrettanto complesso, anche qui ai limiti dell’impossibile. Il motore di ricerca e il suo sistema di inserzioni sono perfettamente integrati, l’uno è parte costitutiva dell’altro e viceversa, l’uno – potremmo dire – risulta essere la condizione di esistenza in vita economica dell’altro. Senza AdWords, e cioè senza il sistema che mette all’asta le parole chiave nelle ricerche degli utenti, su scala globale, cui partecipano gli inserzionisti pubblicitari, e che consente agli azionisti di Google di guadagnare miliardi di dollari al mese, il motore di ricerca diventerebbe completamente altro. Senza AdWords non potremmo pensare a Google com’è oggi.
Un motore di ricerca gratuito, e senza pubblicità, si trasformerebbe in un soggetto dai connotati radicalmente differenti: non sarebbe più una delle aziende più redditizie del pianeta, ma qualcos’altro. Un’istituzione, una fondazione benefica, una organizzazione no-profit, un soggetto giuridico da cui è stato espunta per sempre la capacità di fare soldi.
Destino beffardo per chi ha sempre giocato su un enorme e confortevole equivoco, da chi ha costruito con sapienza una mistificazione nel racconto e nelle immagini affinché gli utenti considerassero l’azienda Google come una specie di istituzione votata al benessere degli utenti. Obiettivo che serviva a farle fare qualunque cosa, al riparo di una missione universale auto-attribuita secondo la quale il compito della società per azioni non era generare profitto, ma organizzare le informazioni mondiali e renderle accessibili e utili a livello globale. Equivoco in cui gli utenti sono caduti con tutte le scarpe, e con essi chi interpretava pigramente le attività delle techno-corporation all’alba del loro predominio globale; tutti negli ultimi 21 anni si sono affidati al motore di ricerca come a un soggetto pubblico che fornisce risposte alle domande dell’umanità intera. Dimenticandone il profilo commerciale e la feroce abilità nel captare i dati degli utenti.
Se smembrare il motore di ricerca separandolo dal suo sistema di pubblicità, pare pressoché impossibile, non altrettanto irrealizzabile potrebbe essere separarlo da una delle tante aziende acquistate da Google, anzi dalla più importante: YouTube. Il player video rappresenta il secondo sito più visitato al mondo, dopo lo stesso Google. Sarebbe un colpo ferale alla primazia del motore di ricerca fondato da Sergey Brin e Larry Page, e lascerebbe Alphabet senza una colossale fonte di reddito. Meno radicale ma altrettanto pesante potrebbe essere l’ipotesi di separare il navigatore e cioè Google Maps. Applicazione sulla quale dalle parti di Google scommettono molto nel futuro.
La procedura di smembramento, in definitiva, non può essere esclusa. Ma dovrebbe essere pensata amputando le techno-corporation negli arti più importanti così da procurare loro una importante menomazione economica; oppure andrebbe pensata in maniera differente rispetto al passato, in considerazione delle enormi differenze con cui le aziende digitale operano e prosperano.
Infine ci sarebbe da capire se una simile procedura ristabilirebbe davvero un ipotetico eden capitalistico, o sarebbe solo un modo per schiantare alcune aziende che hanno osato troppo e troppo hanno guadagnato in così breve tempo.
Molti interrogativi, proviamo a ipotizzare qualche risposta.
Tre.
Molti saranno gli argomenti di difesa che utilizzeranno le aziende digitali per scampare la spada di Damocle che pende sulla loro testa. Uno degli elementi che gli avvocati e gli amministratori delegati utilizzeranno nelle arringhe, sarà perimetrare il cosiddetto mercato rilevante, quello che conta per l’applicazione dell’antitrust. Gli avvocati diranno che ogni piattaforma non opera in uno specifico settore, sia essa la ricerca, i social network, l’e-commerce o il mercato delle applicazioni, ma naviga in un oceano rosso assai più vasto: quello in cui competono tutte le techno-corporation, l’oceano rosso del mercato digitale. Un mercato ampio, pieno zeppo di concorrenti. La pubblicità online, per dirne una, vede oggi tre grandi soggetti: Google, Facebook e Amazon. La concorrenza esiste, questa sarebbe la difesa, ed è agguerrita, perché investe un settore che va osservato con obiettivi dalla focale più ampia.
Ma la Silicon Valley potrebbe anche avanzare un ragionamento differente, proporre una difesa che ha un sapore più politico e che allarga ulteriormente i confini del cosiddetto mercato rilevante.
La competizione nel settore dei servizi digitali, questa potrebbe essere la tesi, non va misurata su scala nazionale ma globale. La competizione per le techno-corporation interessa il pianeta: miliardi di utenti nel mondo, centinaia di aziende, il mercato statunitense è una dimensione geografica, politica e soprattutto giuridica superata; e dunque così antiquato sarebbe qualunque ragionamento che proceda in base a valutazioni di natura territoriale, che insomma giri attorno ai confini nazionali.
Le piattaforme hanno abbattuto quei confini, per questo possono essere interpretate come meta-nazioni digitali. E il territorio su cui estendono il loro dominio, ad oggi, è tutto il territorio del pianeta, a eccezione di Stati in cui la loro presenza è vietata.
Poche aziende rispettano la definizione di meta-nazione digitale come Google, Facebook, Amazon o Apple, ma anche Airbnb, Spotify, Netflix.
Proprio perché il cuore di questi conglomerati digitali è la formula – l’algoritmo – di cui abbiamo già detto, le techno-corporation possono essere presenti e operare, e guadagnare, in quasi tutti gli Stati rappresentati alle Nazioni Unite, con sedi locali, uffici di rappresentanza, budget dedicati alle pubbliche relazioni, lobbisti e un certo numero di dipendenti.
In ogni caso Google non può davvero considerare Bing – cioè il motore di ricerca della Microsoft – come un suo concorrente. Non lo è nella mente delle persone e non lo è, in primo luogo, nei numeri: il raffronto risulta impietoso, il 92,78% delle ricerche contro il 2,55%.
Qual è allora il vero competitore dell’azienda di Mountain View? Se si esclude la presenza più politica, sovranista potremmo dire, del motore russo Yandex, l’unico potenziale concorrente di Google è il motore di ricerca cinese Baidu che oggi possiede una quota di mercato globale per ora insignificante, pari allo 0,9%, cifra che equivale alle ricerche dei cinesi in Cina, in mandarino. Impostazione predefinita: ad oggi sul motore di ricerca cinese l’opzione per poterlo utilizzare in una lingua occidentale non compare. Come sapete non si può utilizzare Google in Cina, ma non sta scritto da nessuna parte che non possa accadere il contrario. E cioè nessuno può escludere che a partire da domani Baidu decida di sbarcare in occidente, di fare concorrenza a Google.
Cosa accadrebbe se il motore di ricerca cinese decidesse di competere sullo scacchiere digitale globale, partendo magari da quei paesi che sono, dal punto di vista geopolitico, nello spazio di influenza cinese? Servirebbero investimenti enormi, uno sforzo comunicativo e di advertising mostruoso ma non impossibile per le tasche di una delle più importanti aziende di Intelligenza artificiale del pianeta. Potrebbe Baidu, ad esempio, cominciare a sviluppare una propria versione in inglese, o nelle lingue dei paesi dall’Africa sub sahariana là dove la presenza cinese è sempre più radicata, in termini commerciali, di investimenti e di aziende. Un’espansione di questo genere potrebbe essere il complemento naturale e digitale dell’attivismo cinese negli altri settori. Un simile scenario è uno scenario che oggi non ha alcun orizzonte di realtà ma non possiamo definirlo irrealizzabile. Dipende solo dalla valutazione degli interessi strategici cinesi. Se qualche elemento che definisce questi interessi varia, o se qualche elemento muta le carte in tavola rispetto alla competizione globale, anche lo scenario complessivo potrebbe cambiare. E capite bene che una Google smembrata, sarebbe un cavallo zoppo nella sfida globale tra i due motori di ricerca, un cavallo senza possibilità di correre, figuriamoci di vincere.
Allo stesso modo l’unico reale competitore di Facebook è rappresentato da WeChat, il social network totale, anch’esso cinese. WeChat è una vera piattaforma integrata che assomma sistemi e funzioni differenti, non solo relazioni tra persone, e quindi messaggi e post, ma anche pubblicità, notizie, pagamenti per l’acquisto di beni e servizi, dalla cena alla visita medica, dal taxi alla vacanza. Una matrioska digitale in cui l’applicazione madre contiene e integra svariate applicazioni figlie. WeChat rappresenta una sintesi perfetta, efficiente, molto facile da utilizzare; un livello di integrazione, tra servizi differenti, che a Menlo Park, sede di Facebook, sognano.
WeChat conta oggi 1 miliardo di utenti, è controllato da Tencent, conglomerato cinese con sede a Shenzhen, nato nel 1998, lo stesso anno di Google. Si tratta di un gruppo da oltre 40 miliardi di dollari di fatturato, che compare al 10° posto nella classifica per capitalizzazione di mercato redatta da Bond per il Rapporto Internet Trend 2019. Tencent produce tecnologia, servizi, giochi elettronici e sviluppa intelligenza artificiale. Insomma un’azienda che non avrebbe particolari problemi se decidesse, con il necessario sostegno del governo cinese, di crescere e allargarsi in altre zone del mondo. Se accadesse davvero, comparirebbe per Facebook il primo vero, serio, pericoloso, competitore globale.
La comparsa sulla scena di TikTok, social network centrato sui video brevi che sta spopolando tra i più giovani, sarebbe a quel punto una specie di antipasto, una prova generale. Eppure TikTok ha già terrorizzato letteralmente l’ecosistema dei social network che fino ad oggi è stata una riserva di caccia di Zuckerberg. E non solo il capo di Facebook appare preoccupato: secondo alcune anticipazioni Google starebbe valutando l’acquisizione di Firework, un’app molto simile. In Cina l’applicazione si chiama Douyin ed è posseduta da Byte-Dance che potrebbe quotarsi a Hong Kong l’anno prossimo con una valutazione che si aggira intorno ai 75 miliardi di dollari.
Amazon allo stesso modo deve già oggi confrontarsi con la potenza di AliBaba Group, e quindi anche delle controllata AliExpress e AliPay. Il conglomerato fondato da Jack Ma non rappresenta soltanto una piattaforma di e-commerce globale ma anche un sistema di pagamenti molto efficiente e utilizzato in Cina, e un fornitore di servizi cloud.
Nell’e-commerce AliBaba sta provando da tempo a uscire dai confini nazionali, e non smetterà di farlo. L’azienda è sbarcata in Sud Est Asiatico, a Singapore e in Vietnam, attraverso la sua controllata Lazada. L’esperimento ha però mostrato, da subito, alcuni limiti nella capacità espansiva: limiti culturali, di comunicazione, di adattamento. Nei paesi in cui è presente ha imposto un modello organizzativo e una cultura aziendale tipicamente cinesi, che non hanno tenuto conto delle specificità del singolo paese. E tutto questo ha generato problemi di inserimento che non sono ancora stati superati.
Se da un lato l’espansionismo in ambito tecnologico non equivale ad aprire sedi, spostare manager fidati e copiare processi di vendita, ma investe differenti fattori, per lo più, attinenti alla capacità di sedurre un intero mercato; dall’altro pensiamo alla pena delle techno-corporation americane che osservano terrorizzate le mosse dei competitori cinesi, mentre sono alle prese con la spada di Damocle maneggiata dai procuratori di cui si diceva in apertura. Una scena da film dell’orrore, in cui un cattivo entra in casa, mentre la vittima è immobilizzata e imbavagliata da un altro cattivo, e l’unica cosa che può fare la vittima è sospirare e spalancare gli occhi: non può reagire e nemmeno fuggire, e soprattutto non può capire quale sia il più cattivo tra i due cattivi.
Partiamo da una considerazione: per quanti problemi abbiano causato all’America, le techno-corporation le aziende californiane giocano un ruolo globale, e tutte in un certo modo esprimono una qualche forma di potere (soft o hard è da vedere) e una qualche forma di influenza a stelle e strisce. Il prodotto che arriva dalla Silicon Valley è un prodotto americano. Per essere precisi si tratta di un prodotto californiano impregnato del vento di libertà che spira su quella sponda del Pacifico. Un prodotto che, a una lettura superficiale, è stato raccontato come la leva che ha sollevato le popolazioni della Primavera araba, e la fionda digitale dei Davide di Hong Kong contro il Golia di Pechino.
La seconda considerazione è che l’influenza delle techno-corporation non è stata pregiudicata dalle ripetute crisi reputazionali che le hanno colpite.
Gli effetti di Amazon sul commercio al dettaglio solo adesso iniziano a essere misurati. Facebook va considerata come una specie di Vaso di Pandora digitale e temporizzato. Ogni tanto si scoperchia ed escono fuori comportamenti illeciti, discutibili: da Cambridge Analytica ai problemi in Myanmar, dai file audio ascoltati e trascritti (per la verità quasi tutte lo fanno) a enormi database di numeri di telefono di utenti lasciati alla mercé di chiunque. Il sentiero delle disavventure di Facebook è colmo di voragini reputazionali. Anche Google è stato multato – 170 milioni – per il mancato rispetto, da parte di YouTube, di norme sulla privacy dei bambini. Ed è incappato in una pessima vicenda di molestie sessuali. L’elenco potrebbe continuare.
Eppure di fronte a queste crisi il business delle techno-corporation – per adesso – non conosce intoppi.
I consumatori continuano ad acquistare su Amazon e le aziende, in tutto il mondo, continuano ad affidarsi sia a Facebook che a Google per la pubblicità, investendo sempre di più, tanto che la pubblicità online ha superato negli Stati Uniti quella sui media tradizionali. E se le aziende si affidano alle inserzioni sul motore di ricerca e sul social network è perché entrambe incarnano, con modalità differenti, una sorta di Santo Graal pubblicitario. Ovvero uno strumento che unisce audience immense a una precisione nell’individuazione dei pubblici che non ha pari nella storia della pubblicità. Non abbiamo assistito a nessun contraccolpo tecnologico: le persone non sono uscite dai social network, non hanno cambiato le loro abitudini, hanno acquistato milioni di esemplari degli assistenti domestici come Alexa o Google Home e continuano a parlare con Siri.
Nonostante quanto accaduto nell’ultimo anno e mezzo, insomma, Facebook, Google, Amazon, Apple e anche Microsoft, non hanno smesso di crescere e di espandersi; a differenza delle omologhe cinesi hanno già avuto successo all’estero e hanno esportato un modello di capitalismo che ha rivoluzionato il presente. Ed è un modello americano.
Insomma se le autorità statunitensi intendessero salvare questo modello di capitalismo a stelle e strisce dovrebbero limitarsi a colpire le techno-corporation con multe, per quanto salate. Un salvataggio presuppone una valutazione positiva del loro valore sistemico, di quanto esse rappresentano a vario titolo l’interesse nazionale; una valutazione che quindi costituirebbe la ragione – non giuridica – delle pronunce dei procuratori dei diversi stati e anche delle autorità indipendenti, e naturalmente del Dipartimento di Giustizia.
Il ragionamento che potrebbe stare dietro a questo genere di valutazione sistemica, come in parte già sottolineato, comporterebbe che la concorrenza nello spazio digitale sai da considerarsi globale per definizione, e che il mercato rilevante, da prendere in esame per capire se le regole sono state violate, possa essere il mondo intero. Limitarsi alla valutazione dei rischi per il solo mercato statunitense e quindi arrivare a sanzioni più pesanti, magari avrebbe anche un senso giuridico, ma potrebbe trasformarsi nell’occasione per le piattaforme rivali cinesi di sfidare le omologhe americane con un vantaggio competitivo fin qui insperato. E cioè quello di vedere i giganti americani alle prese con pericoli e con rischi di smembramento che arrivano da dentro casa. Il tutto mentre le aziende americane e cinesi si stanno sfidando, con l’handicap delle sanzioni e dei dazi, nel settore digitale e in molti altri ambiti.
Se, come scrive Foreign Affaris, “la tecnologia rimarrà al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Cina ben oltre la fine dell’attuale guerra commerciale”, occorre adesso capire se la valanga di azioni giudiziarie contro la Silicon Valley sposterà l’asse di questo conflitto a danno delle techno-corporation americane e a vantaggio di quelle cinesi.
Senza dimenticare che sanzioni pesanti contro queste aziende, paradossalmente, rappresenterebbero l’ennesima manifestazione di quella “territorializzazione di Internet” che negli ultimi anni sta prendendo piede. In maniera differente dalla Russia e dall’Iran, dalla Cina e dalla Corea del Nord, da altre forme proterve di sovranismo digitale, si arriverebbe allo stesso effetto: ridurre la portata e il raggio d’azione di attori che sono stati fin qui globali e che hanno rafforzato la dimensione di Villaggio globale del web, immaginando la rete sempre più come un cortile di casa da amministrare all’interno dei confini politici, da chiudere o aprire, da limitare all’occorrenza. In questo caso le ragioni, rispetto agli intenti degli autocrati che alzano mura digitali, sarebbero altre, tuttavia l’effetto sarebbe più o meno simile.
Pechino sta investendo, e non da oggi, su una lunga marcia verso la supremazia tecnologica, che risale ai tempi del primo e fallimentare “balzo in avanti” di Mao, proseguita con Deng Xiaoping e finalizzata dalle ultime due generazioni di leader cinesi.
Stiamo assistendo da tempo a uno scontro che investe naturalmente anche l’ambito militare e molti altri settori altrettanto essenziali (come le telecomunicazioni, si pensi alle molteplici valenze che ha il 5G), settori che hanno un peso strategico per entrambi gli attori. Le tecnologie che utilizzano Google, Facebook, Amazon e Apple non hanno sempre e necessariamente risvolti che attengono alla sicurezza nazionale, tuttavia le grandi aziende dalla Silicon Valley incidono molto sul budget complessivo che le aziende americane destinano a ricerca e sviluppo in questo settore; inoltre esse rappresentano un esempio plastico della supremazia tecnologica americana che fino ad oggi non è mai stata in discussione. Fino ad oggi, ma non per sempre. Colpirle significherebbe colpire la sostanza di questa supremazia, e colpirne anche un simbolo.
La storia della relazione tra techno-corporation e il Dipartimento della Difesa e di quello alla sicurezza interna, è la storia di una relazione di inevitabile interdipendenza, di mutuo interesse, ed è anche una relazione complicata, nervosa, che ha subito scossoni nel tempo. Una relazione ancora da esplorare dopo che le rivelazioni di Edward Snowden hanno mostrato le cointeressenze tra governo e Silicon Valley in colossali operazioni di controllo e sorveglianza globale. Da quell’episodio molto è cambiato, in peggio potremmo dire, tra i protagonisti di questa complicata e altalenante relazione.
Snowden ha rivelato, oltre ai comportamenti del suo governo, anche la mistificazione costruita intorno alle virtù salvifiche della tecnologia e del digitale; tecnologia e digitale impugnati come vessilli di libertà dalle aziende californiane, si erano trasformati – nel tempo – in strumenti di sorveglianza planetaria grazie alla complicità, all’arrendevolezza, alla compiacenza, di chi un tempo si dipingeva come l’eroe che avrebbe salvato l’umanità da un nuovo Grande Fratello. La Silicon Valley non poteva ammettere con se stessa, con i propri utenti e clienti, che fosse stata messa a un guinzaglio corto e stretto da parte del Pentagono, eppure è ciò che è accaduto. E ha cercato di divincolarsi (si pensi al comportamento di Apple nella vicenda dell’iPhone del terrorista di San Bernardino).
Ma le stesse techno-corporation, alla prova dei fatti, hanno dimostrato di non essere state in grado di difendersi, negli Stati Uniti e altrove, per respingere attacchi esterni, pianificati in maniera meticolosa sul proprio suolo digitale, e quindi di non essere state in grado di reagire alle interferenze russe e di altre nazioni. Certificando, in un certo senso, la dipendenza dal Pentagono quando il gioco si fa più duro.
Quale che sia adesso la temperatura di questa relazione, e senza scomodare ipotesi complottiste, sembra assolutamente plausibile che esista un particolare interesse, da parte delle agenzie di sicurezza federali, per tutto quello che passa nei server delle techno-corporation. Interesse strategico potremmo definirlo. Interesse che concorrerebbe ad alimentare la valutazione circa un interesse di sistema per la sopravvivenza delle piattaforme digitali così come sono.
Nessuno si sognerebbe mai, in ogni caso, di procedere a uno spezzatino per aziende che possiedono un valore strategico per gli Stati Uniti. Non sarebbe nemmeno immaginabile per una Lockheed Martin o una General Electric. Perché dovrebbe essere fatto per Facebook o Google? Sono così macroscopiche le differenze? Siamo certi che il paragone non farà piacere a chi pensa di essere figlio della controcultura californiana e della libertà che si respira nella fornace di Burning Man.
Quale che sia l’analisi più onesta, resta che le decisioni del gruppo di procuratori statali e indipendenti si rifletteranno anche su questi ambiti.
Quattro.
Esistono delle alternative? Esiste una soluzione che tenga conto delle priorità strategiche degli USA e anche del funzionamento – della reputazione potremmo aggiungere – del capitalismo americano?
Possono, insomma, gli Stati Uniti limitarsi a colpire una sola techno-corporation lasciando intatte le altre? Possono, in buona sostanza, utilizzare lo smembramento di una sola di esse come pena esemplare per le altre? E anche come sanzione da esibire, a fronte della domanda di regolamentazione che in tutto il mondo occidentale è venuta fuori negli ultimi due anni.
Se guardiamo agli spiriti animali del capitalismo, nel loro dispiegarsi nell’ecosistema digitale, questi spiriti hanno veramente generato un catalogo piuttosto ampio di danni alle società occidentali, a molte democrazie, comprese quelle di Stati Uniti e Gran Bretagna. Hanno contestualmente prodotto una rivoluzione copernicana nello stesso capitalismo, realizzando immense ricchezze. Adesso per qualcuno sembra venuto il momento di colpire le aziende che questa rivoluzione copernicana hanno stimolato e, in buona parte, prodotto.
Come abbiamo già sottolineato, e com’è evidente, le techno-corporation hanno creato una enorme quantità di problemi in casa, negli Stati Uniti, e fuori, sicuramente in un’Europa che con tutte le debolezze del momento continua a essere alleata degli Stati Uniti. E così la politica estera che esce da una parte, la Cina, rientra impunemente da un’altra, il Vecchio Continente. Che proprio l’Europa, alleato riluttante degli Stati Uniti a guida trumpiana, abbia sofferto importanti problemi di funzionamento della democrazia e della sua fragile architettura istituzionale, anche per colpa di Facebook e Google può essere considerato un dato di fatto. Una sanzione di qualunque tipo alle techno-corporation verrebbe letta sulla sponda orientale dell’Atlantico come un risarcimento, una forma di compensazione, per le svariate tribolazioni post Brexit, per l’incendio populista divampato in molti paesi e per altri temi di minore importanza, ma non per questo meno sensibili, come l’esplosione del fenomeno no-vax, legati alla manipolazione degli algoritmi che ha inquinato il dibattito pubblico.
Più in generale, oggi, qualunque governo nazionale non può fare a meno di prevedere nella propria agenda politica il tema di come rapportarsi a queste creature: che tipo di risposte fornire quando intervengono a squassare un mercato o un settore, come tassarle o come sopravvivere al loro modo di impiegare e reclutare personale. Si pensi alla mobilità o al mercato degli affitti, al commercio al dettaglio. Queste aziende sono figlie di una impostazione economica, di processi produttivi, e soprattutto di una cultura aziendale ispirata alle più grandi e famose 4 sorelle. La decisione di colpirne una sola verrebbe letta dalla platea della tante aziende della tech-economy come un monito, e anche come un invito, difficile da declinare, a sedersi alla tavola dei regolatori per trovare soluzioni condivise nel momento in cui decidono di colonizzare digitalmente un settore di mercato.
La pena esemplare – fuori da ogni considerazione giuridica – sarebbe una risposta decisa ai dubbi e agli incubi che agitano i sonni di tanti governanti nel mondo occidentale.
L’immagine che una sola di esse venga colpita ovviamente stona, ma potrebbe rappresentare una soluzione praticabile in un’epoca in cui il realismo è assurto a paradigma politico e delle relazioni internazionali. E lo scalpo da esibire potrebbe essere quello della più criticata, cioè Facebook. Operazione da concludersi prima delle elezioni del 2020 con la speranza – malriposta – che un’azione di questo tipo possa evitare o limitare le interferenze esterne.
Cinque.
La verità è che le democrazie sono organismi complessi, e lo sono ancora di più oggi di quanto non lo siano state in passato, a causa della globalizzazione che avrebbe reso il mondo, quasi tutto, uno spazio apparentemente sempre più piatto. Ciò che era valido quando si trattò di smembrare la Standard Oil o l’American Tobacco, o in tempi ancora più recenti l’AT&T, non è detto che valga oggi. Il mondo è davvero piatto nello spazio digitale occidentale.
Non esistono protezionismi o barriere da innalzare, non c’è più tempo per negoziati da avviare, il primato globale del social network americano conquistato a suon di acquisizioni pesantissime da Zuckerberg è un dato di fatto, come lo è per le altre aziende della Silicon Valley. Ed è un fatto storico. Ma la storia spesso cambia verso: se in Cina non è possibile – pressoché per tutti – iscriversi a Facebook o a Instagram, in Europa o in America ciascuno di noi può iscriversi e utilizzare WeChat.
Nel digitale, come in ogni altra tecnologia, lo ricorda la legge di Metcalfe, le dimensioni contano. Ecco perché il social network più popolato avrà sempre la possibilità di scalzare i rivali e ridurli a reperti di archeologia digitale. Basta cercare su Google uno dei tanti mirabili, simpatici, e talvolta anche efficienti, social network pre-Facebook per ricordarlo: da Friendster a MySpace. Come sosteneva Eric Schimdt, a lungo presidente di Google, le piattaforme digitali sono semprea un clic dall’estinzione, ecco perché (altra citazione di uno che conosceva bene l’universo della tecnologia, Andy Groove, fondatore della Intel) in questo mondo solo i paranoici sopravvivono.
Senza una paranoia, senza l’ossessione della crescita per società che hanno corso il rischio di non nascere nemmeno in assenza di finanziamenti, il rischio di estinzione è dietro l’angolo; lo è anche per un motore di ricerca, per una piattaforma di e-commerce o per l’affitto di appartamenti, figuriamoci per un social network.
Lo ripetiamo, le ultime performance di TikTok impensieriscono non poco l’ecosistema digitale nel suo complesso. I timori si leggono nei titoli di un quotidiano non qualunque, come il Wall Street Journal, che dedica sempre più spazio a TikTok, cui riconosce una seria strategia per dominare l’universo dei social network. E un gruppo di senatori, sia democratici che repubblicani, avrebbero chiesto al Dipartimento del Tesoro se l’applicazione presenta profili di rischio per la sicurezza nazionale. Il pretesto sarebbero la censura da parte di TikTok dei video delle proteste di Hong Kong.
Certo il successo dell’applicazione potrebbe rappresentare un singolo exploit, oppure il segnale dell’arrivo di un cavallo di Troia da Pechino. L’elemento da non sottovalutare è che la strategia di marketing – dopo gli insuccessi di cui abbiamo detto, relativi ad Alibaba – finalmente funziona. Basti pensare che per raggiungere quota 500 milioni di utenti, l’applicazione ha speso 1 miliardo in pubblicità su una app rivale e cioè Snapchat. Il successo di TikTok indica un primo cambio di passo. La Cina non è più soltanto hardware, non è soltanto la fabbrica fisica della tecnologia, insomma non possiamo più considerarla la nazione che assembla gli iPhone e basta.
Quegli organismi complessi che sono le democrazie prevedono articolazioni che non hanno l’obbligo di tenere conto delle tante variabili di cui abbiamo detto fin qui. I procuratori pensano ad alcune di queste variabili, pensano soprattutto all’applicazione delle norme di legge, valutano i rischi per il mercato e per i consumatori laddove esistono posizioni di forza che stritolano il mercato.
Eppure oggi gli Stati Uniti, e quindi anche i tanti procuratori, paiono di fronte a un feroce dilemma: mantenere in vita il capitalismo e le sue vecchie regole, oppure fare un’eccezione clamorosa, anzi salvare questa eccezione clamorosa, per non perdere una guerra tecnologica con il rivale più ingombrante del nuovo mondo multipolare?
Potremmo applicare una variante dell’Effetto farfalla a questa fase del confronto tra Stati nazionali e techno-corporation (le meta-nazioni digitali), e chiederci se il battito d’ali di un procuratore di uno Stato qualunque influirà sulla supremazia tecnologica americana nel confronto con Pechino. Potremmo anche chiederci se un giudice qualunque si farà strumento di un processo storico inevitabile, quello del sorpasso cinese ai danni degli Stati Uniti in questo settore; o se smembrare le grandi aziende della Silicon Valley sia il passo necessario per la sopravvivenza del capitalismo per come lo abbiamo conosciuto.
Infine ancora occorre domandarsi se è ancora attuale questa affermazione e come possa oggi essere realizzata: «per tutto il corso della loro storia gli Stati Uniti sono stati spesso animati dalla convinzione che i loro ideali avessero un’importanza universale e che fosse necessario diffonderli». Se risulta ancora vera, questa affermazione è vera nella misura in cui quegli ideali sono stati diffusi anche attraverso un sapiente racconto del capitalismo, narrazione in cui si inscrive alla perfezione il big bang dell’universo digitale proprio nell’ultimo capitolo di questa storia.
Le techno-corporation conservano, rispetto alle concorrenti cinesi pochi vantaggi, per lo più di natura non tecnologica, su tutte la loro genesi californiana e la loro dimensione, e poi il modo di raccontarsi, il rapporto con Hollywood, la connessione con un ecosistema omogeneo, la relazione con le università, la finanza e i venture capital e, infine, il complesso militare industriale.
La controparte cinese ha fin qui invece enormi problemi a imporsi in uno spazio geopolitico e culturale che oltrepassa i confini della Repubblica Popolare, fa eccezione rumorosa – come già sottolineato – TikTok.
La differenza enorme sta, per le aziende californiane, nel considerare lo spazio digitale come uno spazio fisico i cui confini sono stati abbattuti e valicati; le controparti cinesi hanno fin qui valutato lo stesso spazio come un territorio difeso, protetto, recintato da qualcuno che non ha – apparentemente – nulla a che vedere con l’universo digitale, e cioè il governo di Pechino.
In ogni caso, sfogliando il Rapporto Internet Trend 2019, il predominio delle techno-corporation statunitensi, per valore di mercato, è ancora indiscusso: tra le prime 10 società quotate, ben 8 sono americane e solo due cinesi. Tra le prime 20 la proporzione cambia di poco: 14 sono aziende a stelle e strisce, 5 sono cinesi e una sola è giapponese.
Non sappiamo se la Cina abbia un interesse strategico coincidente con quello che vogliono tutelare i procuratori americani, fin qui non sembra; non sappiamo nemmeno se grazie agli effetti delle decisioni dei giudici americani, Pechino deciderà di espandersi, sfruttare la conseguente debolezza delle techno-corporation californiane e costruire un processo equivalente a quello del Belt and road nel web, di cui è difficile immaginare il tracciato e i protagonisti.
Ma come la nuova Via della Seta fisica sta riconfigurando la geopolitica globale e ridisegnando aree di influenza e commerci di una parte consistente del pianeta, siamo certi che, se dovesse prendere corpo una Digital belt and road, essa produrrà una riconfigurazione complessiva dello spazio digitale attuale dalle stesse caratteristiche.
Il grande dilemma che agita gli Stati Uniti, in realtà agita anche buona parte del mondo occidentale: l’esito di questo ennesimo conflitto tra governo americano e techno-corporation potrebbe mutare il panorama del web per come lo conosciamo oggi.